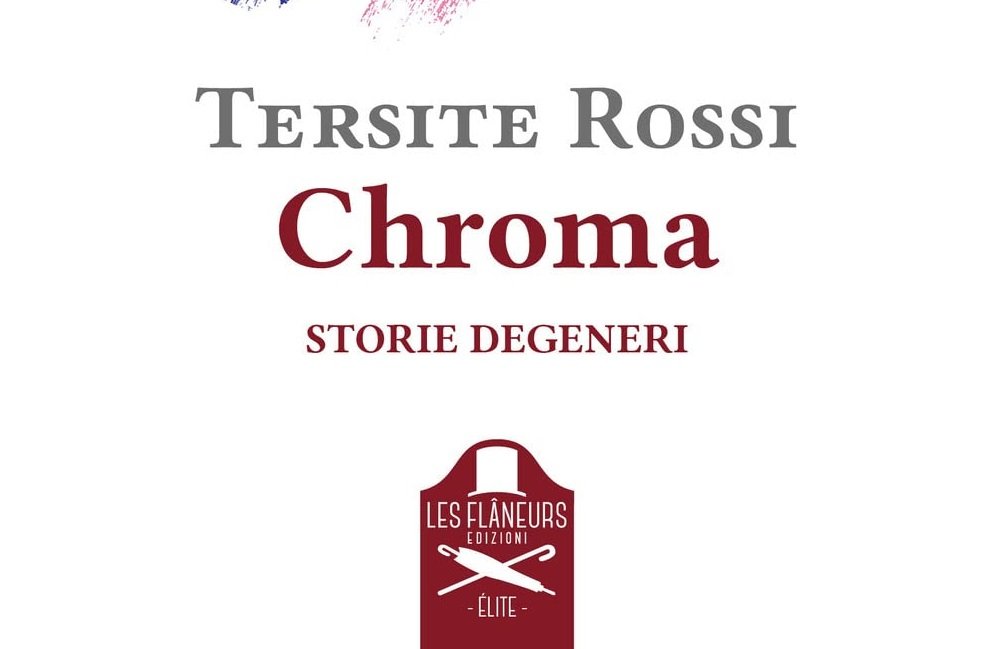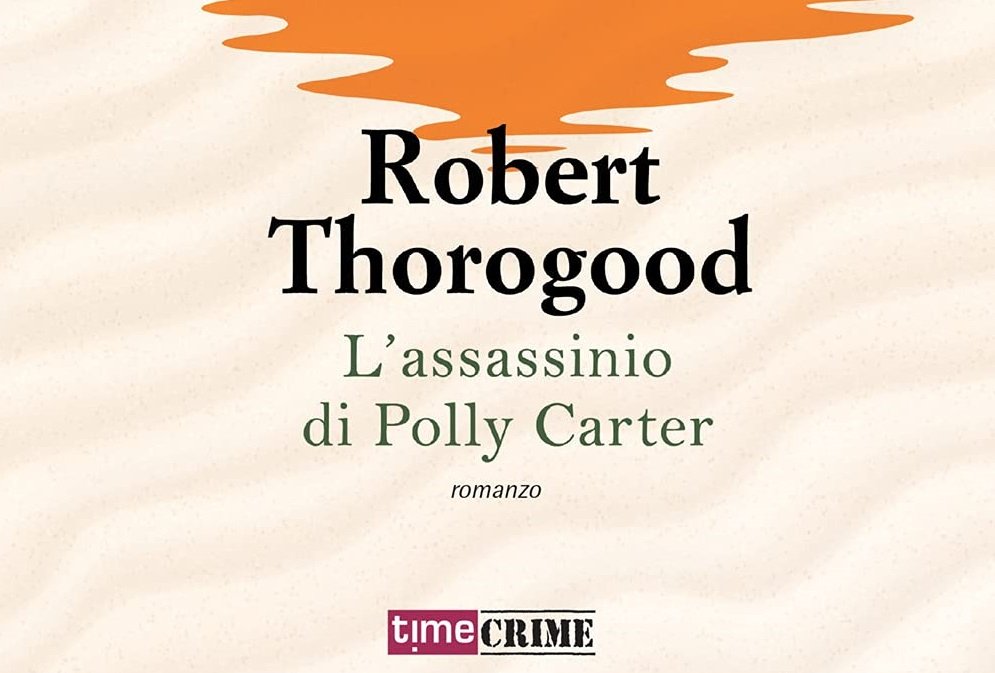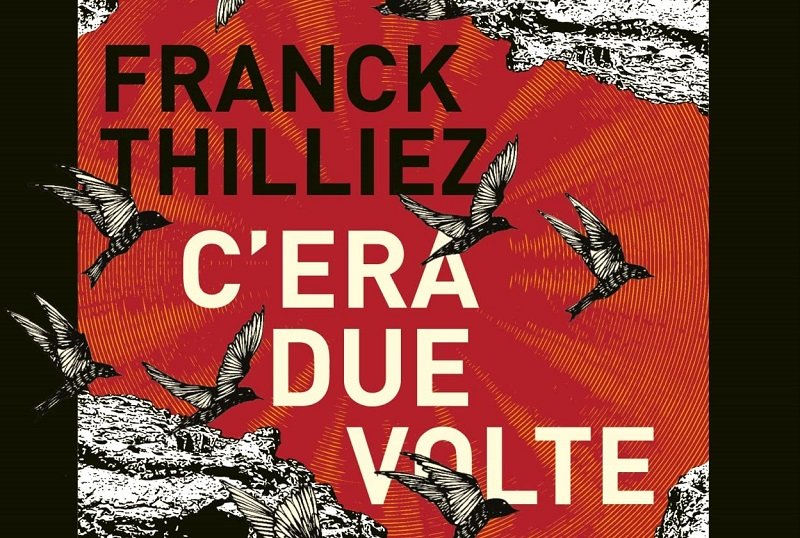“Sicilian Ghost Story è una fiaba nerissima, una pellicola gotica ad alto contenuto noir per raccontare fatti di cronaca inenarrabili.” Con questi pochissimi caratteri sul profilo Twitter di Milano Nera riportavo la mia impressione su un prezioso esempio di film italiano in concorso per il Premio Caligari al Noir in Festival 2017.
“Sicilian Ghost Story è una fiaba nerissima, una pellicola gotica ad alto contenuto noir per raccontare fatti di cronaca inenarrabili.” Con questi pochissimi caratteri sul profilo Twitter di Milano Nera riportavo la mia impressione su un prezioso esempio di film italiano in concorso per il Premio Caligari al Noir in Festival 2017.
Ambientato in Sicilia tra il ’93 e il ’95, per la precisione nel periodo in cui fu sequestrato Giuseppe Di Matteo. Un ragazzo di 15 anni, vittima di mafia, ucciso nel tentativo di far desistere il padre Santino Di Matteo dalla collaborazione con le forze dell’ordine. Il lungometraggio ripercorre la notizia di cronaca, ma da un punto di vista molto particolare. Sovverte i cliché di genere ed è lontana da certe produzioni didascaliche e appiattite. Dal punto di vista visivo, offre allo spettatore una Sicilia buia, schiacciata da un cielo grigio e affogata da una forte pioggia battente, mentre il taglio narrativo deraglia dalla solita storia di mafia verso una narrazione gotica tout court, in cui la ribellione e la lotta all’omertà passano attraverso la purezza e la forza di un amore vero.
La sinossi breve serve per incuriosirvi e spingervi a recuperare il prima possibile Sicilian Ghost Story: Giuseppe scompare dopo aver trascorso un pomeriggio con la sua compagna Luna. Nonostante i continui contrasti della madre verso i sentimenti di lei, aiutata dall’amica del cuore, si ribellerà al fatalismo – atteggiamento in bilico tra complicità e rassegnazione – con cui tutti cercano di rimuovere quanto accaduto. La sua passione la porterà a naufragare nella parte oscura della realtà per ritrovare l’amato e instaurare un rapporto che trascende i limiti dello spazio e del tempo.
In rete spesso si abusa di alcuni termini per esprimere il proprio giudizio verso alcune opere. Definendo Sicilian Ghost Story un gioiello, non voglio partecipare alla svendita degli elogi perché è davvero un ottimo esempio di quanto ancora il cinema italiano possa offrire in patria e all’estero. Non voglio addentrarmi in una sterile polemica contro l’attuale decadimento della cultura in Italia, ma segnalare come Fabio Grassadonia e Antonio Piazza dimostrano come sia ancora possibile fare bene dell’arte in grado di spazzare via il solito pattume e offrire aria nuova da respirare.
Anche se esistono diverse coppie, di norma alla regia si è abituati a pensare a un solo regista dietro alla macchina da presa. Per meglio capire il vostro rapporto e metodo di lavoro, vorrei che vi presentaste da soli.
Fabio: sono di Palermo e ci sono rimasto fino alla fine degli studi universitari. Nel ’94 mi sono trasferito a Torino dove ho frequentato un master biennale in tecniche della narrazione e dove ho cominciato a lavorare per alcune case editrici come lettore e correttore di bozze. Nel ’96 l’incontro con Antonio che in quell’anno iniziava il master mentre io dopo il diploma ci ero rimasto a lavorare. Nel ’98 il docente di sceneggiatura gli chiede di scrivere come esercizio un soggetto per una serie televisiva e Antonio mi chiede di farlo insieme. Il progetto piace al docente che ci propone di trasferirci a Roma per provare a diventare sceneggiatori. Accettiamo e nell’autunno del ’98 ci trasferiamo a Roma dove frequentiamo il corso di fiction televisiva Rai. Poi una decina di anni da sceneggiatori, sia per la televisione che per il cinema, in entrambi i casi nulla di significativo, qualche consulenza per qualche casa di produzione cinematografica e nel 2007 la decisione di smettere quello che stavamo facendo e provare a raccontare le nostre storie mettendo mano alla nostra esperienza di vita siciliana, entrambi siamo cresciuti a Palermo negli anni ’80 e ’90, i più cupi della recente storia di Sicilia.
Antonio: anche io sono di Palermo e ho vissuto nella mia città sino a venticinque anni. Ero dunque un ragazzino negli anni ’80, gli anni delle guerre di mafia, della Palermo come Beirut, la Palermo dello scontro tra clan mafiosi che insanguinò la città dal 1979 al 1986, con un bilancio terribile di migliaia di morti, la “mattanza”, mentre il resto d’Italia viveva la frenesia degli anni Ottanta. La “Milano da bere” e la “Palermo per morire”. Strade inondate di sangue e di denaro, per il traffico di stupefacenti: questa era la nostra città, qui andavamo a scuola e studiavamo. La bomba che uccise Rocco Chinnici esplose a pochi metri da dove vivevo con i miei genitori. Eppure quel giorno lo stesso partimmo per le vacanze, facendo tutti finta di niente, mentre davanti casa lasciavamo uno scenario di guerra. Anni dopo, negli anni ’90, ero uno studente universitario, sempre a Palermo. Sono gli anni delle stragi e dell’attacco dei corleonesi contro lo Stato. Sono gli anni che hanno visto formarsi la mia coscienza antimafia, il mio senso critico nei confronti della realtà che mi circondava. Cominciai a impegnarmi in politica – erano anche gli anni della così detta Primavera di Palermo, la prima esperienza amministrativa di Leoluca Orlando come sindaco – e nelle associazioni di resistenza antimafia, diventando anche giornalista per alcune televisioni private palermitane. In quelle prime esperienze giornalistiche scoprii un primo e rozzo istinto verso la narrazione, una sorta di piacere di “raccontare storie”, anche come modo di esprimere rabbia e disgusto, i sentimenti prevalenti allora, insieme alla passione civile. Solo l’incontro con Fabio mi ha permesso di portare questo istinto, questo piacere della narrazione verso una forma più matura, più compiuta. Solo nel dialogo con lui ho avuto le chiavi per capire e rielaborare in modo creativo le cose che mi stavano a cuore, le ferite legate a Palermo e alla Sicilia.
Ora che sappiamo chi è l’uno e chi è l’altro, vorreste descrivere come riuscite a lavorare assieme?
Fabio: L’istinto, il bisogno di lavorare insieme è stato immediato. Imparare a farlo ha richiesto anni, molti scontri, un gran dispendio di energie nervose. Prima abbiamo dovuto imparare ad accettare ognuno il carattere dell’altro e poi a metterci a servizio e ad arricchire le qualità l’uno dell’altro. Condividiamo naturalmente la dedizione nei confronti di ciò su cui lavoriamo e lo studio di certi temi. Il momento più intenso di conflitto è ancora oggi il processo di scrittura. Giunto al termine quello, il resto è più semplice perché a quel punto condividiamo ogni scelta, sia da un punto di vista drammaturgico che di messinscena. Entrambi amiamo coinvolgere nel processo creativo le persone che nelle varie fasi concorrono alla realizzazione del film. Ognuno deve poter portare qualcosa di proprio all’interno del film, qualcosa che arricchisca e approfondisca le intuizioni e le suggestioni presenti nel copione. Per Sicilian Ghost Story possiamo dire di essere stati particolarmente fortunati, a cominciare dall’incontro con Nicola Giuliano e il meraviglioso gruppo di lavoro di Indigo Film.
Antonio: non è un caso che siano spesso le coppie di fratelli a dirigere insieme, perché occorre condividere molto di più di una sceneggiatura, molto di più della visione artistica. Occorre avere una sorta di comune weltanschauung, una concezione simile, o almeno accostabile, complementare, del mondo, della vita, e della posizione che nel mondo occupano gli esseri umani. Dunque, è qualcosa di raro e anche molto fragile. Qualcosa che proteggiamo e che alimentiamo in una dialettica costante nella quale tendiamo a coinvolgere i collaboratori di cui più ci fidiamo, come è successo con Luca Bigazzi per Sicilian Ghost Story, entrato nella nostra incessante conversazione creativa con intelligenza e vera passione.
Entrambi siete gli autori della sceneggiatura di Sicilian Ghost Story, ma dove e come è nata l’idea?
Fabio: La storia di Giuseppe Di Matteo è la ferita più profonda della nostra esperienza di vita in Sicilia perché è il culmine dell’orrore di quegli anni, il punto di degrado più profondo della “civiltà” siciliana. Per noi era però impossibile raccontare quella storia nell’ambito dello stretto realismo perché è una storia senza redenzione alcuna per nessuno, soprattutto per la vittima. Nel 2011 abbiamo letto il racconto “Un cavaliere bianco”, contenuto nella bellissima raccolta di racconti “Non saremo confusi per sempre” di Marco Mancassola. Ogni racconto ha al centro un caso di cronaca della recente storia italiana, casi controversi che hanno lasciato ferite aperte nel nostro tessuto sociale. “Un cavaliere bianco” racconta la storia di Giuseppe Di Matteo ma sui fatti reali Marco innesta un’invenzione fantastica che senza tradire la verità storica e morale del fatto, strappa dal buio delle nostre coscienze il ragazzino e schiude una inaspettata possibilità di redenzione. Abbiamo subito riconosciuto che quello era il solo modo per noi di avvicinarci a Giuseppe e alla sua storia.
Antonio: Il racconto di Mancassola, di cui parla Fabio, ci ha schiuso un orizzonte nel quale la storia di un orrore indicibile poteva essere trasfigurata. Il dono vero del racconto è stato la scelta di un punto di vista, un punto di vista dal quale iniziare tutto, quello di una ragazzina, una compagna di classe di Giuseppe innamorata di lui. Il film inizia proprio nel giorno in cui Luna consegna a Giuseppe una lettura d’amore che per troppo tempo non ha avuto il coraggio di consegnare. Questa scelta ha cambiato di segno alla narrazione, consentendoci di creare lo spazio della favola nera e della storia d’amore, entro cui potere rendere un atto d’amore nei confronti di Giuseppe, cercando di portare il suo fantasma dall’oscurità in cui era precipitato, l’oscurità delle nostre coscienze, delle coscienze di tutti, verso la luce.
Avete sovvertito parecchi cliché narrativi e paesaggistici per narrare un tremendo fatto di cronaca, senza svilirlo o spettacolarizzarlo. Come e perché avete intrapreso questa direzione?
Fabio: la narrazione di mafia e delle vittime di mafia è diventata in gran parte solo una forma parassitaria d’intrattenimento che alimenta mitologie discutibili e consolazione a buon mercato. Per noi stare alla larga dall’utilizzo canonico del genere e dei suoi sottogeneri è il punto di partenza. Nel caso di Sicilian Ghost Story sentivamo il bisogno di un atto d’amore per Giuseppe e di speranza per le ragazze e i ragazzi della sua età che in Sicilia devono costruire il proprio futuro sul paesaggio desolato che le generazioni precedenti hanno apparecchiato per loro.
A proposito del cast, Luna è un personaggio molto importante, è il motore di tutta l’opera, cosa vi ha spinto a scegliere Julia Jedlikowska come protagonista?
Antonio: Luna ha 12 anni nel film, Giuseppe è suo coetaneo. Il casting del film è durato nove mesi, un tempo lunghissimo. Perché dovevamo cercare dei ragazzini siciliani, inevitabilmente alla prima esperienza. Il film si regge molto sulle spalle della protagonista femminile e trovarla non è stato facile. La prima cosa che ci ha colpito di Julia è stato il suo modo di camminare, ci diverte pensare che camminando diciamo un po’ chi siamo. Sin dal primo incontro ci è sembrato che Julia avesse quel misto difficilissimo di intelligenza, introversione e struggente vulnerabilità, che sono gli elementi costitutivi del personaggio di Luna, insieme alla sua ostinazione.
Come valutate lo stato attuale del cinema italiano e chi, secondo voi, può apportare nuova linfa dentro e fuori i confini nazionali?
Antonio: è un momento positivo, per molti versi. Ci sono tanti autori, riconosciuti e amati anche all’estero, e una grande vitalità creativa. C’è una voglia diffusa di abbattere gli steccati tra cinema commerciale e cinema d’autore e di riprendere a usare i generi cinematografici, che avevano fatto in passato la fortuna dell’industria del Cinema italiano. Le nuove leggi sul Cinema contribuiscono a rafforzare il contesto produttivo. Rispetto al passato il pubblico guarda con sempre minore diffidenza ai film italiani e anche in un anno di crisi come il 2017, la quota di mercato del cinema italiano resta alta. Le serie televisive italiane sono amate ed esportate in tutto il mondo e la crescente attenzione alla serialità di qualità aiuta anche a ripensare i film destinati alla sala cinematografica. C’è ancora tanto da fare, per esempio sul tema della distribuzione. Per noi e per molti altri colleghi, è doloroso constatare la mancanza di attenzione e strategia a lungo termine che segna l’arrivo in sala di troppi dei nostri film più belli, distribuiti senza un’adeguata promozione, senza una vera riflessione su come quello specifico film possa incontrare il suo pubblico. Anche per i film che vengono selezionati ai festival o che vincono premi importanti, bisogna ripensare i meccanismi di distribuzione. Non ci si può affidare solo al traino di Cannes o Venezia, che è importante, ma non basta più. Se non ci sono soldi, almeno si deve investire tempo e creatività. Bisogna crederci.
Non è un’intervista se non finisce con la classica “progetti futuri”. Volete anticiparci qualcosa?
Antonio: dovremo smettere di viaggiare in giro per il mondo per la promozione di “Sicilian Ghost Story”, tornare a casa e riflettere. Al momento ci sono solo idee, non progetti veri e propri. Sicuramente, dopo il nostro primo film “Salvo”, che era un noir, e dopo questo secondo, mix particolare di generi come favola nera, mafia, ghost story, dramma e biopic, continueremo a esplorare confini e intrecci di generi cinematografici. E siamo felici di potere continuare a farlo con Indigo Film.
Grazie della disponibilità e buon lavoro.
Qui il trailer ufficiale di Sicilian Ghost Story