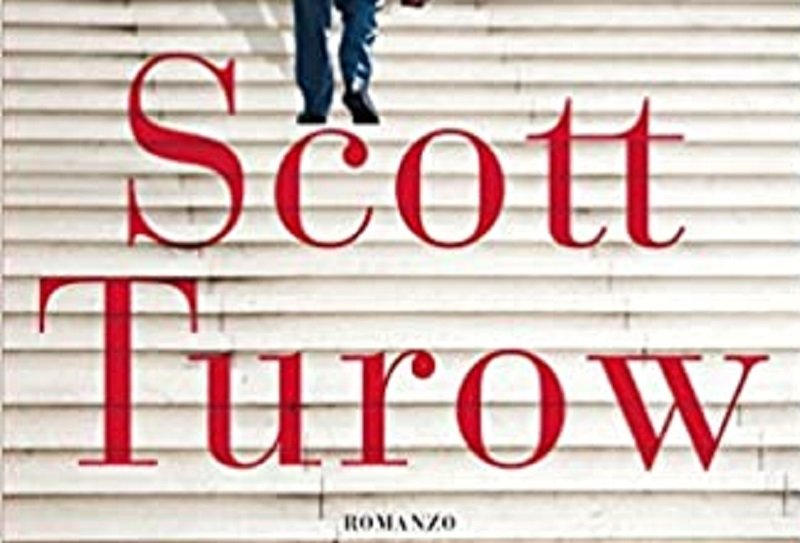Riportiamo qui sotto un interessante articolo apparso oggi sul quotidiano La Stampa a firma Sebastiano Vassalli in cui si intervista ROBERTO CERATI, prima direttore editoriale, ed oggi presidente, della casa editrice Einaudi
Il mercato editoriale secondo il mitico direttore commerciale. Einaudi: trucchi, strategie e i ricordi dei grandi autori del ‘900
Una conversazione con Roberto Cerati � un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro del libro in Italia. Ottantacinque anni portati benissimo, in ufficio dalle sette e mezza del mattino alle sette di sera, Cerati � stato per decenni il direttore commerciale della Casa editrice Einaudi e l’alter ego di Re Giulio, con cui aveva maturato un rapporto che si potrebbe definire di �simbiosi�, pi� che di amicizia o di collaborazione. Ora � il presidente di una casa editrice (l’Einaudi, appunto), che fa parte del gruppo Mondadori. Un uomo riservato, che d� pochissime interviste e che non � mai apparso in televisione. Uno degli ultimi protagonisti silenziosi, in questa Italia che sgomita e schiamazza davanti alle telecamere.
Partiamo dall’inizio. L’avventura di Cerati con i libri incomincia nell’estate dell’ormai lontanissimo 1945, a Milano in viale Tunisia, dove sta nascendo la rivista-simbolo del primo dopoguerra: Il Politecnico di Elio Vittorini. Gli incontri fondamentali sono quelli con Einaudi e, appunto, con Vittorini; il mercato del libro, quando Cerati inizia la sua avventura, � quasi inesistente in provincia e nelle citt� maggiori � legato a librerie e case editrici le cui origini risalgono all’Ottocento: Hoepli, Seeber, Bocca, Le Monnier, Paravia, Laterza… Bisogna inventare nuovi lettori a cui proporre nuovi libri. Per fare fronte a questa scommessa, Cerati arriva a vendere Il Politecnico in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, in concorrenza con gli �strilloni� del Corriere della Sera e degli altri quotidiani. Un inizio che � gi� leggenda.
Un altro incontro importante di quegli anni � quello con il libraio Cesarino Branduani della Hoepli. �Per definire un libro, o per dare un consiglio, Branduani usava due modi: l’� b�n e al va. Al va era il libro che si vendeva bene, che andava da s�; ma l’altro libro, il libro b�n, bisognava averlo sempre disponibile, anche se la sua vendita era meno facile e pi� lenta. Purtroppo – dice Cerati -, questa filosofia del vecchio libraio con l’andar del tempo si � persa. Oggi l’editoria tende a controllare tutte le fasi del mercato, dalla produzione al consumo. Esiste un solo tipo di libro, quello che al va e che perci� � anche b�n. Il libraio � un commesso cui viene assegnata una certa quantit� di ogni libro. Cos� vanno le cose: ma io credo che, pian piano, si dovr� tornare alle vecchie distinzioni. Bisogner� ricostruire un sistema informativo che serva a distinguere il libro b�n da quello che al va; e il libraio sar� ancora un mediatore importante, come ai tempi di Branduani�.
Torniamo a parlare del passato. Il mercato del libro, in Italia, nasce negli anni Cinquanta del secolo scorso a opera di alcuni protagonisti. Ci sono i librai che vengono da Pontremoli in Lunigiana, i famosi �pontremolesi�; ci sono le prime librerie Feltrinelli e quelle che nascono, soprattutto in Emilia, per conto dei partiti di sinistra; nel Sud, ci sono le iniziative benemerite di qualche pioniere. L’Italia vive la trasformazione pi� profonda della sua storia moderna: dall’agricoltura all’industria, dalla campagna alle citt�. Arrivano l’automobile, la televisione, la scuola dell’obbligo. Arrivano, nella valle del Po, i librai pontremolesi con le loro bancarelle; qualcuno, addirittura, � analfabeta, ma riesce a distinguere i libri dalle copertine. Quando parla dei pontremolesi, dei Tarantola, dei Lorenzelli, dei Giovannacci, dei Lazzarelli, dei Fogola… a Cerati brillano gli occhi. �I pontremolesi arrivavano con le bancarelle e in qualche caso con delle semplici ceste piene di libri; l’obiettivo era �tirarsi sotto il tetto�, cio� aprire un negozio stabile, e lo raggiungevano nel giro di qualche mese, al massimo di qualche anno. Non erano persone colte, ma come librai erano imbattibili. Bravissimi a vendere ci� che al va, il loro orgoglio era per� il magazzino. Guadagnavano e investivano in libri. Quando ricevevano la visita di un altro pontremolese, dicevano: gli ho fatto vedere il mio magazzino, e quasi gli veniva un colpo…�.
Il rapporto con gli scrittori: �Contrariamente a quanto pensano alcuni, Cesare Pavese era un uomo molto attento a ci� che gli si diceva, e anche molto gentile. Una volta eravamo per strada: io avevo la mia borsa personale e avevo anche la valigetta con il campionario dei libri… A quell’epoca, avevamo il campionario delle copertine da far vedere ai librai. Pavese mi prese la valigetta, disse: questa te la porto io. Un’altra volta eravamo da Simone, che era un’osteria in via Stampatori, e io gli proposi di pubblicare le commedie di Eduardo De Filippo. Lui scosse la testa; poi, per�, seppi che aveva chiesto un parere a Muscetta, e poi Einaudi pubblic� De Filippo…�. Gli chiedo com’era Calvino da giovane. Io, Calvino l’ho conosciuto nel 1970, quando gi� era impegnato a recitarsi nella parte di Calvino… �Era un furetto. Aveva sempre qualcosa da fare ed era bravissimo nel cogliere il centro di una questione, nel riassumerne gli aspetti pi� salienti. La chiarezza e la sintesi erano le sue virt��.
Parliamo di Elsa Morante (�una donna molto malinconica�), di Sciascia (�aveva il complesso di non sentirsi amato dalla casa editrice�), di Bassani, di Testori, di Rodari, di Primo Levi e perfino di Tomasi di Lampedusa. Un Tomasi di Lampedusa intravisto in un caff� di Palermo mentre sta scrivendo…
Il tempo � passato e ci sono ancora due domande che devono assolutamente essere poste. La prima �: come ha potuto la pi� prestigiosa casa editrice italiana fallire per motivi economici? �Il mercato cresceva – mi risponde Cerati – e il nostro capitale azionario era assolutamente insufficiente per finanziare la crescita. Dipendevamo dalle banche, con il costo del denaro fino al 18 per cento. Pi� vendevamo, pi� perdevamo. Sembra un paradosso, ma � ci� che � successo�.
Seconda domanda obbligata. Come si sente l’alter ego di Giulio Einaudi, all’ombra di Mondadori e di Berlusconi? �Non ci sono inquietudini n� difficolt�, almeno per il momento. Non ci sono inquietudini perch� il progetto editoriale non � sottoposto a pressioni esterne; e non ci sono difficolt�, perch� la politica gestionale del gruppo Mondadori � stata uno stimolo indispensabile per la crescita della casa editrice�.
SCHEDA
Roberto Cerati, presidente dell’Einaudi dal 1999, quando mor� il fondatore, � stato per decenni l’anima segreta della casa editrice, il direttore commerciale che ha sempre privilegiato il catalogo, il teorico della piccola ristampa e della diffusione a macchia d’olio sul territorio negli anni Settanta, quando lo Struzzo deteneva un �potere culturale� incontrastato. Si erano incontrati, lui e Giulio Einaudi, nel ’45 a Milano. L’allora giovane editore gli propose semplicemente di �provare a vendere qualche libro�, Cerati cominci� a girare l’Italia in treno, libraio per libraio, e non si ferm� pi�. Divenne l’alter ego del �principe�.
Si dice che nella celebre riunione del mercoled� non parlasse quasi mai, limitandosi a consultare i suoi fogli. Poi c’era, al gioved�, il faccia a faccia tra lui e Einaudi. Discutevano di titoli, prezzi, e soprattutto di quali libri �spingere�. Era quella la riunione pi� temuta da autori e redattori, dove ci si intendeva con poche parole. In questa sede, ad esempio, Cerati convinse Einaudi a lanciare La storia di Elsa Morante, in tascabile a basso prezzo (2 mila lire nel ’74): una delle prime strategie di marketing moderno.