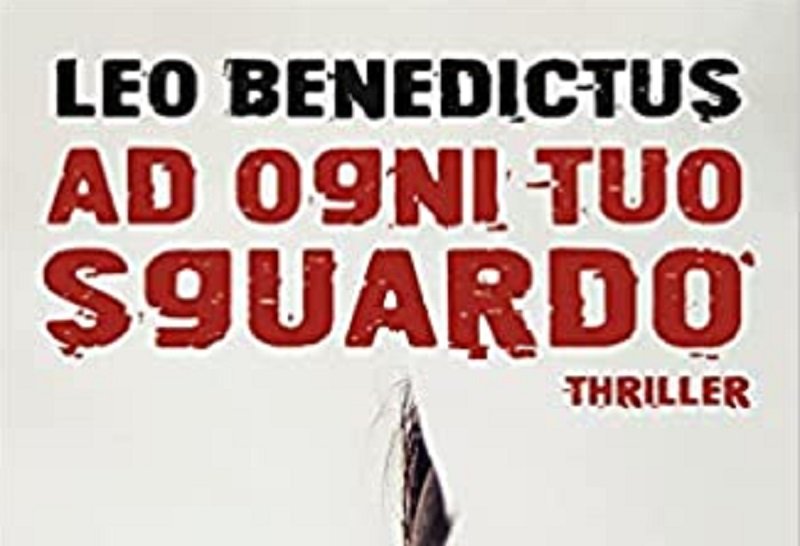Luigi Guicciardi ha analizzato alcuni scrittori italiani dal pedigree letterario illustre che si sono cimentati, inaspettatamente, per la prima (e spesso unica) volta con il romanzo giallo, cercando di rispondere a qualche domanda: s’è trattato di “veri” gialli? In che cosa stanno dentro a un genere, e in che misura invece lo sopravanzano? Che cosa hanno mutuato dai canoni del mystery o del thriller, e in che cosa invece li hanno superati o violati? E, anche, in che cosa consiste oggi la loro notevole attualità?
Insospettabili “giallisti” italiani degli anni ’90
Tra il 1994 e il 1999 alcuni scrittori italiani dal pedigree letterario illustre si sono cimentati inaspettatamente – per la prima (e spesso unica) volta – con il romanzo giallo, da Dacia Maraini a Raffaele Crovi, da Manuzzu a Tabucchi, da Bevilacqua alla Morazzoni e a Ongaro. Obiettivo di questa rassegna critica è dunque quello di analizzare le ragioni, i limiti e i caratteri di queste singolari opzioni narrative, cercando di rispondere ad alcune domande. Si è trattato di “veri” gialli? Che cosa hanno mutuato dai canoni del mystery o del thriller, e in che cosa invece li hanno superati o violati? In che modo stanno dentro a un genere, e in che misura invece lo sopravanzano?
Partiamo allora da Dacia Maraini che, reduce dai successi di Marianna Ucrìa e di Bagheria, debutta nel giallo nel 1994 col best seller Voci (Rizzoli), tutto strutturato su una detection al femminile (c’è una giornalista radiofonica che porta avanti un’indagine personale sull’assassinio di una vicina di casa, all’interno di un’inchiesta professionale sulla violenza urbana contro le donne). Ma già dentro – o tra le pieghe – della struttura dell’indagine, formalmente ineccepibile, con tanto di co-protagonista istituzionale, la commissaria Adele Sòfia, emerge qualcosa che si differenzia dalle peculiarità o dagli stilemi del “genere”. Si focalizza e si approfondisce, infatti, un tema umano e sociale di tragica attualità: la solitudine, l’incomunicabilità, l’alienazione nella nostra civiltà (che è al tempo stesso un recupero aggiornato di un tema portante del grande romanzo borghese del Novecento, da Svevo a Pirandello). Altra tematica inquietante risulta poi la città contemporanea, vista come “una società di isole rigorosamente separate da una fitta ipocrisia discrezionale”, con le psicopatie e i disturbi della sfera sessuale nella realtà metropolitana (dietro l’apparente normalità del quotidiano), spesso emblematicamente sintetizzati nelle sevizie sulle donne. E il quadro appare arricchito da un’indagine psicologica esplicita (perché tante donne, oggi, sono violentate e uccise? perché nella maggior parte dei casi i colpevoli non vengono individuati? perché soprattutto sono le stesse donne, spesso, ad aprire la porta ai loro assalitori?) e da una inquieta dimensione “filosofica” che – di là dalla soluzione specifica del caso – filtra fin dal titolo: “Ogni voce ha il timbro della verità, che non sempre coincide con quella logica delle cause e degli effetti cara alla giustizia…”
Un “giallo”, quindi, particolare, problematico, articolato su dimensioni plurime (tra psicologia, sociologia, relativismo filosofico), di lettura solo apparentemente facile o evasiva, tutt’altro che imperniato sulla logica primaria della tensione narrativa o della suspense, che pure non manca: tant’è che da questo libro fu tratto il film omonimo di Franco Giraldi (2001), seppur con location liberamente trasferita da Roma a Genova.
Allo stesso 1994 appartiene anche Il terzo suono (Einaudi) di Salvatore Mannuzzu, con i suoi ingredienti polizieschi apparentemente classici, ortodossi, ineccepibili: un autunno in Sardegna, un gruppo di villeggianti, un professore ucciso con un colpo di rivoltella in testa, e poi il fuoco, a volerlo sfigurare; il nipote del morto come principale indiziato, nipote che è anche amico della figlia del poliziotto incaricato delle indagini. Un poliziotto, questo, maldestro come investigatore e non meno maldestro come padre, “pesce lesso” per i colleghi, meteoropatico e nevrotico, ma non privo di una sua logica procedurale e umana, coerente e stoica, che lo rende alla fine affascinante. Con tutto questo, però, l’indagine narrata costituisce subito anche qualcosa di diverso, di oltre il giallo: un’occasione, cioè, per una presa di coscienza del rapporto fra padre e figlia, che – come tanti altri, oggi – sembra quasi non esistere, ma in realtà perdura fortissimo (e fondamentale nell’ossatura dell’intreccio).
Siamo quindi di fronte, col Terzo suono, a un romanzo “modernamente” giallo, che, anziché sfidare il lettore solamente a una gara “interpretativa” dell’assassino, intende porsi come chiave di lettura della nostra vita, come struttura generale per raccontare la realtà (per dirla col vecchio Vazquez Montalban), e anche come pretesto per narrare come si vive male questo nostro tempo.
Del giallo, dunque, ci pare che Mannuzzu colga formalmente i meccanismi strutturali (il cadavere iniziale, l’inchiesta, l’interrogatorio), ma affidando poi al suo “sguardo obliquo” sulla realtà il compito di un’altra inchiesta, più profonda, sulla vita e sull’uomo.
Quindi, non solo giallo, ma per la prima volta nella narrativa di Mannuzzu un romanzo diverso, sintesi del suo percorso narrativo precedente, tra gli anni Ottanta e Novanta: dai misteri giudiziari di Procedura alle analisi psicologiche dei racconti della Figlia perduta, sino alle frantumazioni della verità e alle reticenze delle Ceneri del Montiferro, Una sintesi che intensifica, insomma, il personale discorso di questo scrittore sulla corrosione delle cose e sulla corruzione dei sentimenti a opera del tempo, e sui sedimenti del tempo stesso, sempre più dolorosi e dal significato più ambiguo, più opaco.
Altro scrittore senza bisogno di presentazioni è Raffaele Crovi, fuori da ogni logica di “generi”, caratterizzato semmai da una costante polemica contro i conformismi (politici, culturali, ideologici) del nostro tempo, intonato a una lucida amarezza civile e cristiana, sia come scrittore di vangeli apocrifi (Parabola,1995), di poesie o di romanzi storici (tra cui La valle dei cavalieri, 1993, Premio Campiello). Partendo quindi da altre esperienze (ma già nel 1977 aveva curato una nota antologia di giallisti nostrani, Buon sangue italiano, compendiando poi nel 2000, con Le maschere del mistero, una vita da lettore di thriller), anche Crovi approda nel 1996 al romanzo “giallo” con L’indagine di via Rapallo (Piemme), ambientato in una Milano precisa e natalizia (dal 23 dicembre 1995 al 3 gennaio 1996), con frequenti aperture cronistiche e statistiche sulla realtà della città. E’ appunto un altro giallo, questo, dalla struttura in apparenza ineccepibile: c’è la vittima, qui significativamente uno scrittore, Orio Zaniboni (che stava progettando un romanzo, Boomerang, “sulla regola della ritorsione”, ispirandosi agli inquilini del suo stesso stabile), caduto, o fatto cadere, da una finestra del suo palazzo di via Rapallo 7; c’è il detective, un vicecommissario che si finge cugino del morto, prende possesso del suo appartamento quale unico erede e comincia a indagare dall’interno. E c’è l’indagine, che coinvolge in una catena di sospetti ogni abitante di un palazzo milanese paradigmatico. Ma ancora una volta – dietro e oltre l’intreccio giallo – il romanzo si impegna a raccontare la Milano contemporanea, con scontri sociali, emarginazioni e conflitti fra modernizzazione e degrado dell’habitat, proprio mentre l’inchiesta poliziesca ricostruisce la vita di un palazzo di otto piani dove, come in un villaggio verticale, uomini e donne si misurano sbandati con la propria solitudine. Basti pensare, al riguardo, agli emblematici personaggi: una mannequin, un usuraio, una guaritrice, due ladri, un politico fallito, una donna in carriera, un gay inquieto, un deejay, il proprietario di un eros center, e così via.
Anche Crovi, dunque, parte dal giallo, dalla sottile conoscenza della suspense, per svolgere un’altra indagine (implicita e parallela), con passione e ironia, sulle microviolenze quotidiane, che è anche metafora del disordine del mondo, e della solitudine del cittadino metropolitano di oggi.
Dopo l’impegno civile di Sostiene Pereira, ecco tre anni dopo La testa perduta di Damasceno Monteiro (Feltrinelli, 1997), ispirato ad Antonio Tabucchi da un atroce fatto di cronaca portoghese, con l’andamento di un thriller, a partire dal ritrovamento di un cadavere decapitato per proseguire con le indagini di un giornalista, Firmino, e poi di un avvocato, detto Loton, ricalcato fin dal nome sul Laughton del film Il caso Paradise. Bizzarro e metafisico, aristocratico e anarchico insieme, vinto dalla vita – come altre figure di Tabucchi – ma lontano dalla rassegnazione, Loton collabora con Firmino sino alla soluzione del caso: il contrabbando di droga per opera della polizia corrotta. Ma ancora una volta – e a maggior ragione per un libro dell’autore di Pereira – la struttura poliziesca dell’indagine (nei modi anche di un’inchiesta giornalistica, quasi cronaca di un fatto di cronaca…) focalizza ben altro che lo scioglimento finale di un mistero, ritraendo cioè, e sottoponendo alla riflessione – dietro la metafora narrativa e con notevole spessore stilistico – i grandi temi dell’abuso di polizia, della tortura, della giustizia, della marginalità sociale e delle minoranze etniche. Problemi, come si vede, della pur suggestiva Oporto, nella fiction, ma insieme – oltre il genere giallo – di tutta l’Europa civile, nella realtà del nostro tempo.
Tra le piccole sorprese, sempre del 1997, si colloca a un certo punto un interrogativo: possibile che Alberto Bevilacqua, l’analista delle psicologie complesse della Califfa e Questa specie di amore, l’autore innovativo e sperimentale dell’Occhio del gatto, approdi anche lui al giallo quasi alla fine del millennio? Ebbene sì, con Gialloparma (Mondadori, 1997). Ma si tratta anche qui, a ben guardare, di un giallo-pretesto, di un giallo-occasione, come lo stesso scrittore ha dichiarato, offrendoci la giusta chiave di valutazione del proprio romanzo – esteriormente ispirato, nella trama e nell’atmosfera cittadina, a un noto caso di cronaca mutino-parmense – e insieme anche le parole giuste a interpretare indirettamente altri “gialli” di autori alti, che qui stiamo campionando:
“In che senso la vicenda che qui racconto è giallo? Nel senso che, del genere, ha il congegno narrativo, la suspense, e via dicendo. Nel senso, soprattutto, che io per primo ho provato il piacere di tenere avvinto me stesso dalla prima all’ultima pagina. Questo piacere lo trasferisco ai miei lettori e mi auguro che possano farlo proprio. La storia, dunque, non si esaurisce nell’intrigo, nella pura enigmistica dell’indagine, eccetera. Sono mezzi strutturali per far emergere ben altro. (…) Perché una storia così è logico che abbia più facce: può intendersi come storia d’amore, anche se rovescia tutti i canoni; come storia di ironie e di rivelazioni stupefacenti; infine come storia su di un tema che mi è caro da sempre: il desiderio (delle emozioni, della felicità, per quanto è possibile). Cosa non si fa perché questo desiderio non muoia. Persino l’enigma di un delitto paradossalmente può servire.”
Così l’autore. Storia d’amore, di ironie, di desideri, dice lui. Ma anche storia dei vizi di una città di provincia, aggiungo io, estesi nel ’97 a vizi nazionali, di un’intera società. E’ dunque la complessità dei significati, e l’articolazione interpretativa, a differenziare, per lo stesso Bevilacqua, il romanzo anche giallo dal giallo tout court.
Il 1997 è anche l’anno de Il caso Courrier (Longanesi) di Marta Morazzoni, e anche in questo caso la descrittrice finissima di psicologie della Ragazza col turbante, de L’invenzione della verità (1988, Premio Campiello), di Casa materna e de L’estuario, così attenta a una sottile alchimia di passioni nascoste, segreti, pulsioni di coscienza, aderisce a una trama apparentemente gialla: il suicidio del signor Courrier, un mistero assurdo, inspiegabile agli occhi di tutto il paese (che è Orcival, nell’Alvernia, nel 1917). Inspiegabile, perché tutto, nella vita dell’uomo, era apparso integerrimo, anzi programmato, con lucida meticolosità, con immobile regolarità, fino alla pedanteria: dall’attività redditizia, alla moglie virtuosa, alla stima e al rispetto sociale. Eppure il colpo di pistola che pone fine a questa vita induce un intero paese all’incredulità, a un moto di risentito stupore, poi ad anni e anni di supposizioni frustrate, di congetture irrisolte… Ecco, del giallista la Morazzoni ci sembra avere una virtù, almeno: la capacità cioè di far percepire al lettore – nelle pieghe della trama, nel divenire della storia – la tensione imprecisata, la presenza inavvertibile che avvolge la vita (quello che per noi è il mistero). Ma detto questo, l’analogia finisce. Non c’è infatti, in lei, interesse per la detection logico-induttiva o per lo scioglimento finale (secondo necessità e ragione), ma solo per l’interiorità dei personaggi, le cui esistenze obbediscono sempre a un’intrinseca fatalità, a un destino che – persino nei gesti più trasgressivi come il suicidio – le costringe a rimanere tragedie intime, invisibili, non spiegate (e perciò non “gialle”). C’è quindi, come in certa grande narrativa europea novecentesca, il tema del caso (immotivato), del fato oscuro, che di là da ogni causa s’insinua nella vita e a poco a poco, con misura, la erode fino ad annientarla (come accade con Alphonse Courrier): “l’idea di quel quid”, dirà la stessa autrice in un punto, per noi, pirandelliano, “della variabile impazzita che sballa le regole del gioco e spiazza i giocatori…”
E anche lo stile semplice, leggero, ma innervato di grande letterarietà (che ricorda a tratti certa moralità manzoniana), esprime sì un realismo non estraneo in sé all’universo del “giallo”, ma un realismo (a ben vedere) increspato, scalfito dal senso dell’attesa, di qualcosa che dovrà accadere inevitabilmente, improvvisamente, che ci richiama alla mente Buzzati…
Alberto Ongaro, narratore veneziano di storia e d’avventura – La taverna del doge Loredan, Il segreto di Caspar Jacobi e soprattutto La partita, Premio Campiello 1986 – già predisposto alla suspense, alle indagini e ai misteri, ha stupito meno di altri col suo approdo finale al “giallo” con Hollywood Boulevard del 1997. Perché di vero poliziesco o thriller sembrerebbe trattarsi finalmente, stando almeno alla trama, che ci mostra un giovane italiano a Los Angeles, biografo di star famose, intenzionato a scrivere la biografia di un grande regista di origini polacche, ma traumaticamente impedito dalla morte improvvisa di quest’ultimo e da un dischetto che il regista gli fa avere prima di morire. Sul computer del giovane si snoda così una storia misteriosa e avvincente: c’è un elenco di delitti, una serie di nomi, tutti da interpretare. Il progetto di una sceneggiatura? La base per un film da realizzare? Il file ha la sequenza di un’indagine e lui allora la segue, nei meandri di una vicenda incompiuta, dietro i fili lasciati in sospeso, trasformandosi in detective. “Si era lasciato prendere dal gusto del gioco”, parola-chiave del romanzo, “dal sistema di regole della suspense.” E quando il file si interrompe, capisce che non può più sottrarsi a questa storia nella storia, che lui stesso ne è diventato parte, e che l’eredità telematica del regista è il segno di un destino inevitabile, di cui egli stesso sarà indagatore e vittima…
Perché la verità finale lo porterà a scoprire l’esistenza – in un mondo moralmente sovvertito dalla televisione e dalla “civiltà” dell’immagine, da audience, share e tubi catodici – di un Circolo imprecisato e onnipotente, che decide “per gioco” la morte di qualcuno, per riprenderla segretamente in video e gustarne lo “spettacolo” e scommetterci anche su… E un brano, al riguardo, ci sembra esemplare:
“Forse era stato l’uso sempre più bieco della televisione a suggerire a qualcuno l’idea di organizzare clandestinamente spettacoli criminali. Ora vi faremo vedere noi fino a che punto si può arrivare. Qualcosa di veramente cattivo, perdio. Che ce ne facciamo di guerre che sembrano film, di morti ammazzati che sembrano comparse imbrattate di salsa? Sponsor danarosi e ben disposti avevano aperto la strada a un gioco infame fine a se stesso (…) Tutti gli omicidi erano stati commessi davanti alle telecamere, era questo il legame. Vedeva le telecamere puntate, e assieme alle telecamere i lontani terminali, gli innumerevoli schermi nelle innumerevoli case negli innumerevoli paesi che avevano mostrato la loro morte in diretta a innumerevoli occhi. Il sistema televisivo nel suo complesso.”
Anche in Ongaro, dunque, non solo “giallo”, ma anche temi aggiornati sulla contemporaneità, tragicamente inquietanti e precocemente recepiti, tra letteratura e (soprattutto) cinema: tra La morte in diretta di Tavernier (1980) e l’imminente The Truman Show di Peter Weir (1998), sulla responsabilità della televisione, con la Real TV di Ongaro in funzione o al servizio di uno “show criminale”, nella cancrena etica di una nuova civiltà (telematica, dell’immagine) che ha ormai perduto ogni valore che non sia quello del “gioco”.
E in perfetta chiusura circolare si conclude nel 1999, con Dacia Maraini, la nostra rassegna di Autori Illustri prestati al giallo. Tratto d’unione, nei dodici racconti di Buio (Rizzoli), appare il ritorno della commissaria Adele Sòfia, già nel romanzo Voci del ’94, e anche qui non mancano crimini e vittime (di sfruttamento, stupro, omicidio) ispirati dalla cronaca, e poi interrogatori, interni di questura, tecniche d’indagine; ma qui più che mai – e quest’ultimo esempio può essere un paradigma – la commissaria risulta un personaggio-pretesto (che a volte interviene solo alla fine della storia, nelle ultime righe), e il “giallo” si fa occasione per raccontare un dramma preciso della nostra epoca, la violenza – non solo sessuale – sull’infanzia e sull’adolescenza. L’inchiesta tocca quindi vicende attuali, che emergono dal Buio metaforico della coscienza collettiva: un ponte di tenebre che l’amore non può, non ha ancora potuto, restituire alla luce. Viene in mente a proposito la frase di un grande giornalista: “Ci sono tanti morti nella mia vita, ma il più morto di tutti è il bambino che io sono stato.” Ecco, potrebbe esser questa l’epigrafe più adatta per tante persone sopravvissute agli orrori della propria infanzia, la conclusione di una generazione infelice (e di questo nostro excursus).